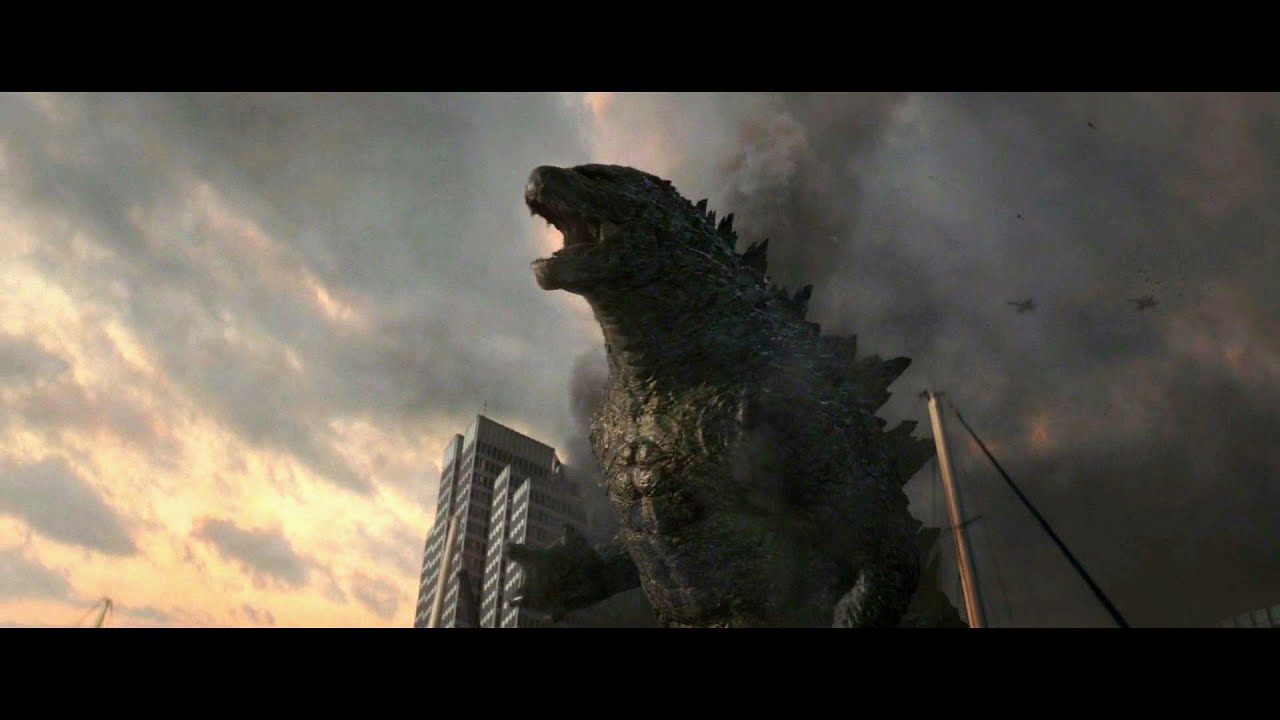"The Departed" (2006), in Italia "The Departed - Il bene e il male", diretto da Martin Scorsese, è un poliziesco nero che rielabora liberamente il film asiatico "Internal Affar" (2002) (e la trilogia di cui fa parte).
In una Boston particolarmente essenziale e quasi anonima, relegata com'è sullo sfondo della vicenda, la malavita irlandese (guidata da un boss dal cognome italiano) infiltra un proprio uomo nella Polizia di Stato, mentre un'unità della stessa Polizia scarta un aspirante poliziotto per poi proporgli comunque di entrare sotto copertura nella malavita irlandese.
Da qui si sviluppa una narrazione parallela della missione dei due giovani, di come siano sempre sul punto di smascherarsi a vicenda, del loro rapporto con i superiori, siano essi il capitano di Polizia o il boss criminale: come ampiamente sottolineato dalla critica, un tema fondamentale della loro esistenza è la ricerca di una figura paterna che sostituisca quella effettiva, perduta troppo presto.
La specularità dei quattro personaggi in questione è estremamente evidente, quasi schematica nella sua esposizione, tanto che i due giovani finiscono per amare e condividere la stessa donna, nonchè stabilire legami col "padre" dell'altro, ma non va confusa col fine ultimo della narrazione, il quale è invece riflettere sulla natura dell'essere umano. Il sottotitolo italiano, con cui concorda la critica, sostiene che tale riflessione verte sul "bene" e sul "male" che coesistono nell'uomo e che determinano le scelte e le azioni dei due protagonisti, entrambi costretti a fingersi diversi da ciò che sono, mentre militano tra le fila del nemico.
Ma, a voler ben guardare, il film non sembra interessato alle categorie di "bene" e di "male", nè tanto meno a discettare sulla loro esistenza: la guerra tra malavita e Polizia è declinata solo in meri termini di legalità e illegalità, e le scelte dei due protagonisti non sono determinate da un'incertezza tra "bene" e "male", quanto dall'esigenza di sopravvivere, di forgiare rapporti umani per rendere sopportabile la vita, e infine di definire la propria identità come persone. E' in questa ottica puramente individualista che i due giovani (le palesi facce della stessa medaglia) mentono, uccidono, tradiscono, scelgono e vivono, in contrapposizione al comportamento ben più astratto dei loro "padri putativi", i quali ormai conducono la loro esistenza in un certo modo perchè quello è il modello che ormai hanno interiorizzato e da cui non sanno più staccarsi, sebbene abbiano perso di vista i motivi per cui lo seguono (questo aspetto è particolarmente sottolineato dal boss malavitoso, che a 70 anni suonati continua a delinquere, a fare sesso trasgressivo in modo meccanico, senza obiettivi per il futuro, ma è anche un informatore dell'FBI per garantirsi la libertà di soddisfare i propri capricci di narcotrafficante, come il suo "figlioccio" gli rinfaccia e come la sua prostituta filosofa gli fa spesso notare). E quindi il vero tema di un film è forse la preponderanza dell'istinto di sopravvivenza dell'essere umano, che fa facilmente strame di secoli di civiltà e religione e strutture sociali e filosofia ed etica, quando sono gli interessi personali a venire intaccati.
Scritto e diretto in maniera lineare, elegante e sicura, il film è coinvolgente, trascinante e intrigante, e riesce ad affascinare e a tenere lo spettatore incollato per tutti i suoi 151 minuti, nonostante il tono di fondo nero fino alla disperazione, intriso di un pessimismo che nega ogni redenzione, e non si attenua neppure nel finale con soprese multiple, in cui all'ecatombe di personaggi di ogni lato della barricata fa seguito la morte dell'unico superstite, che in teoria se la sarebbe meritata, ma nella pratica ci ha dimostrato di avere un proprio senso dell'onore e ci è quasi divenuto simpatico, pur nella sua perdizione.
Involontariamente, il film offre anche qualche momento lieve. Il premio della critica va infatti alla psichiatra della Polizia, la più imbranata, vulnerabile e dilettantesca che sia mai vista: si fa abbindolare e sedurre dall'infiltrato in cinque secondi, si lascia turbare e sedurre dal rabbioso poliziotto sotto copertura, è oggetto di manipolazioni psicologiche da chiunque le rivolga la parola, e non coglie il minimo indizio su niente della personalità di chicchessia. Non ha mai avuto pazienti, prima di questo film? E' uscita dall'università il giorno prima? Se questo è il supporto psicologico che la Polizia del Massachussets dà ai suoi uomini, non c'è da stupirsi che l'organizzazione vada a rotoli.
Regia, fotografia e sceneggiatura filano di comune accordo, nel raccontare la vicenda con grande perizia e fascino, sia visivamente che in termini di ritmo e dialoghi: considerando il regista coinvolto, è impossibile sollevare lamentele sotto questi aspetti. Il citazionismo colto è all'ordine del giorno, sia esso in senso cinematografico (riferimenti a film di gangster classici come "Little Ceasar", "Scarface") che storico (il boss criminale è basato sulla reale figura del criminale Whitey Bulger, che fu anche un informatore dell'FBI).
E' un po' diverso il discorso degli attori, dove la coesistenza di così tante celebrità funziona molto bene finchè si parla di Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg e Martin Sheen, tutti capaci di delineare con cura il loro personaggio nei due aspetti fondamentali (e cioè introspettivamente e in termini di relazioni con gli altri personaggi). Per Jack Nicholson, notoriamente, questo non vale: i suoi eccessi di protagonismo esasperatamente istrionico, la sua resa fin troppo sopra le righe ed esagerata del laido e squinternato boss criminale, le continue bizzarrie (improvvisate?) quasi in ogni una scena, finiscono per stancare, nonostante regia e montaggio facciano del loro meglio per impedire all'attore di strabordare e di compromettere la logica della narrazione in funzione di un esibizionismo che sfocia sempre nella stessa figura narrativa (il pazzo fuori controllo).
 Non stupisce che Mark Whalberg abbia ricevuto un riconoscimento come attore non protagonista, data l'intensità con cui rende il suo aggressivo e furibondo personaggio secondario del sergente di Polizia, il cui vero ruolo non può essere apprezzato se non alla fine, nel momento in cui la sua piccola parte finalmente acquisisce il senso e lo scopo che merita.
Non stupisce che Mark Whalberg abbia ricevuto un riconoscimento come attore non protagonista, data l'intensità con cui rende il suo aggressivo e furibondo personaggio secondario del sergente di Polizia, il cui vero ruolo non può essere apprezzato se non alla fine, nel momento in cui la sua piccola parte finalmente acquisisce il senso e lo scopo che merita.
La colonna sonora utilizza sia brani rock e pop già esistenti sia nuove musiche composte da Howard Shore, rendendo con efficacia l'atmosfera tesa, drammatica e nello stesso tempo piena di energie ribollenti sotto la superficie dei protagonisti: la cifra irlandese di Boston è ottimamente resa da trascinanti brani come "I'm Shipping Up to Boston" dei Dropkick Murphys.